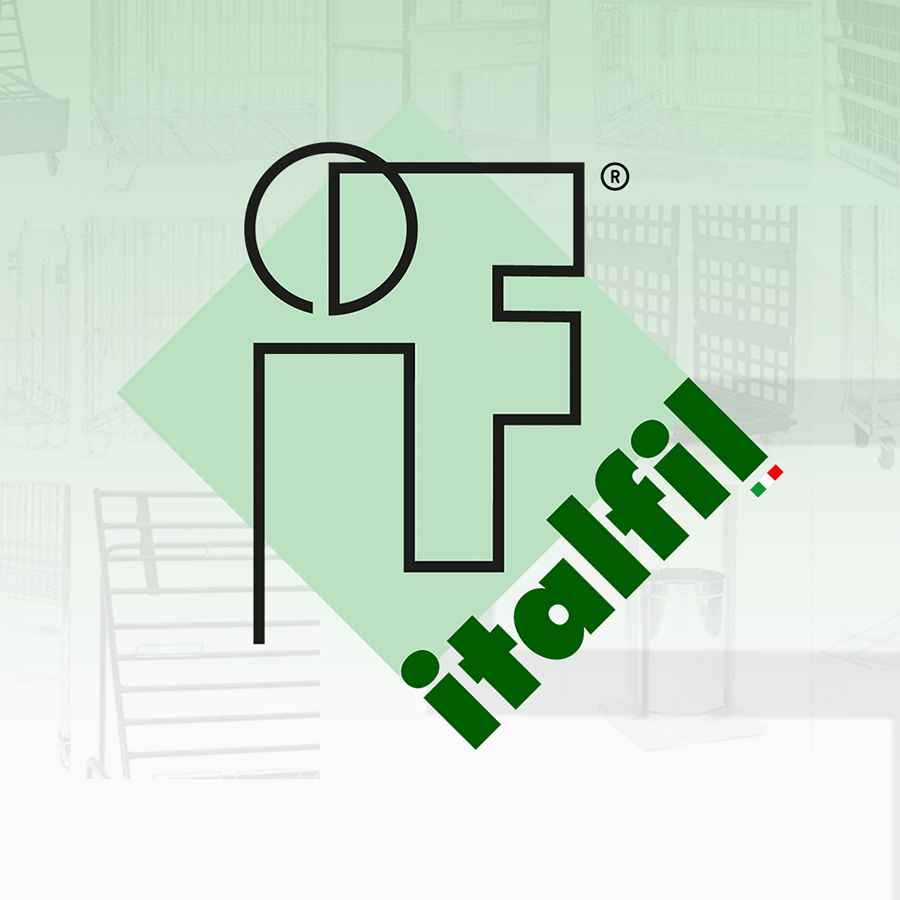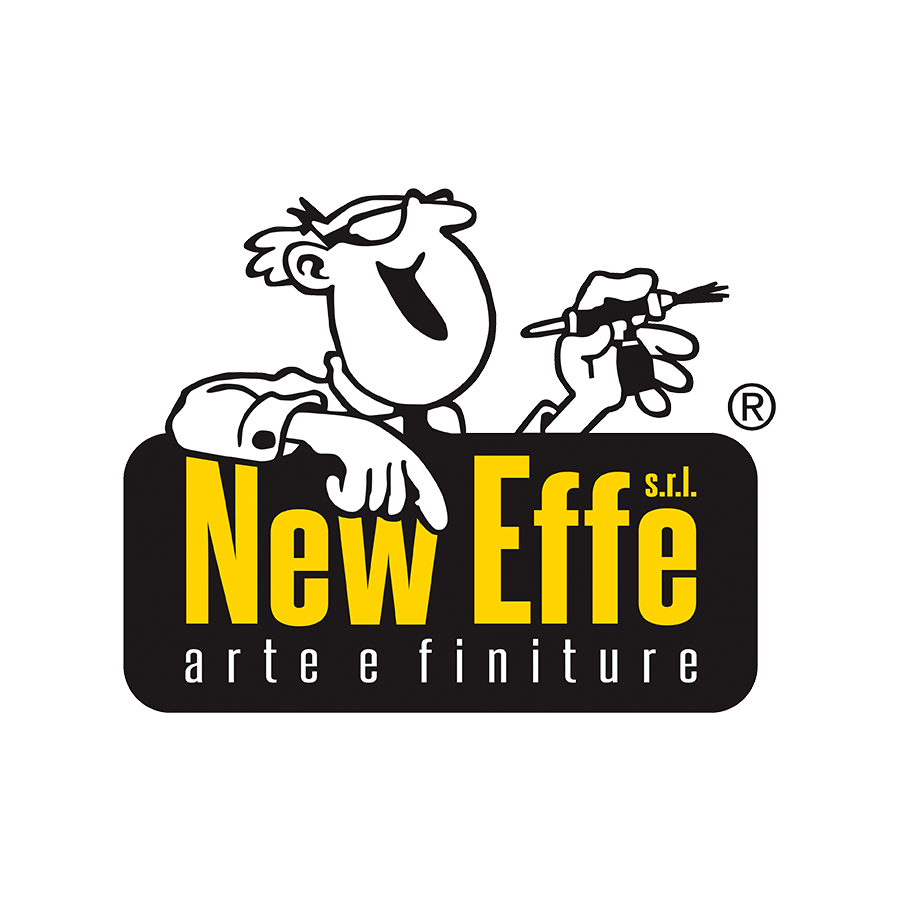Otto minuti e quarantasei secondi.
Per otto minuti e quarantasei secondi, Derek Chauvin, poliziotto di Minneapolis, Minnesota, ha forzato il suo ginocchio e con esso il peso del suo corpo sul collo di George Floyd, quarantaseienne Afroamericano.
In questi otto minuti e quarantasei secondi, Floyd ha usato tutta la forza che gli restava per implorare, chiamando ‘Mamma!’ ed esclamando “I can’t breathe, please, I can’t breathe”. Lo stesso “I can’t breathe”, ‘non riesco a respirare’ di Eric Garner, soffocato a morte a New York nel 2014 dal poliziotto Daniel Pantaleo durante un arresto per sospetto di vendita di sigarette di contrabbando. Lo stesso “I can’t breathe” stampato sulle maglie di molti giocatori del NBA, frase divenuta motto di un movimento omonimo nazionale e che ha poi dato vita a Black Lives Matter (Le vite nere contano).
Qualcuno, allora come in questi giorni, tenta di rispondere all’affermazione ‘Le vite nere contano’ estendendola a, “All Lives Matter”, “Tutte le vite contano”. Impossibile confutare o contrastare la validità teoretica di questa frase, principio assoluto ed inderogabile di quasi tutti gli ordinamenti giuridici ed iscritta nei principali Trattati internazionali che racchiudono i fondamenti dell’assetto morale ed etico dei Paesi firmatari.
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, firmata a Parigi dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, di cui gli Stati Uniti sono tra i fondatori, sancisce all’articolo 3 che “ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”.
La stessa Dichiarazione d’Indipendenza degli USA, che risale addirittura al 1776, dichiara notoriamente che “tutti gli uomini sono creati eguali, muniti dal loro Creatore di certi diritti inalienabili tra cui la libertà, la giustizia e la ricerca della felicità”.
La frase “Black Lives Matter” appare quindi talmente ovvia, umanamente quanto legalmente, da essere ridondante e perciò tendenziosa.
È però interessante analizzare la ciò che il legislatore Statunitense intendeva quando redasse e firmò queste disposizioni.
La Dichiarazione d’Indipendenza fu firmata da Thomas Jefferson, primo Presidente degli (ormai indipendenti) Stati Uniti d’America, il quale ebbe più di seicento persone schiavizzate al suo servizio durante la sua vita.
La Dichiarazione di Parigi risale 1948, sei anni prima che nella sentenza Brown v. Comitato dell’Educazione, 347 U.S. 483, la Corte Suprema superasse e quindi, di fatto, rendesse illegale (trattandosi di un sistema basato sul precedente giurisprudenziale) la segregazione di bianchi e neri al livello statale nell’educazione pubblica. Non fu fino al 1964, dopo l’uccisione da parte dei servizi segreti di Martin Luther King e Malcom X, che L’Atto dei Diritti Civili venne approvato a livello federale, annullando quindi tutte le leggi statali che imponevano la segregazione razzista. Fu solo nel 1965 che le persone nere ebbero effettivamente il diritto di voto, dopo che furono abolite le terrificanti ed aberranti leggi “Jim Crow” nel Sud controllato dal KKK e i cavilli legali congegnati per impedire l’esecuzione del XV emendamento, che avrebbe dovuto estendere il suffragio agli uomini afroamericani già nel 1870.
Fino al 1917, le politiche di urbanistica potevano essere – ed erano – legalmente ideate in modo da isolare i neri; fu così che si crearono i “ghetti”, zone a bassa affluenza economica, dimenticate dallo Stato che ci entrava – e ci entra – solo con la polizia. La scarsa qualità dell’educazione, dovuta al sistema di attribuzione di fondi controintuitivo, la strategica criminalizzazione di determinati comportamenti, il totale abbandono istituzionale, le pessime condizioni abitative ed il costante razzismo interpersonale e delle autorità, hanno allargato il divario tra bianchi e neri, quest’ultimi già svantaggiati da secoli di schiavitù, al termine dei quali non sono stati forniti degli strumenti necessari per affrontare la vita in “libertà” mentre i loro ex “proprietari” (come se si potesse mai davvero possedere un essere umano) furono indennizzati per la loro perdita di “forza lavoro”.
Il razzismo si era insediato talmente tanto nel tessuto, nella fibra sociale del Paese, da far sì che i cittadini si sostituissero allo Stato con l’assordantemente tacita complicità dello stesso, emanando regole per i proprietari terrieri o di immobili, di regola bianchi, che vietavano loro di vendere o affittare a neri in determinate zone delle città, la violazione di queste disposizioni substatali era sanzionata come se avessero forza di legge.
Il sistema di realtà statunitense è stato fuorviato, o meglio, originariamente fondato, sul razzismo, che offriva alla massa bianca povera una sorta di consolazione divina, quella di, almeno, non essere neri, i quali erano invece destinati ad occupare la base della piramide sociale, anche questo per ordine cosmico trascendentale delle cose.
Ovviamente il tempo è passato e la legge si è indirizzata verso un concetto di eguaglianza reale e sostanziale, così come ha fatto la società civile, come esemplificato dall’elezione di Obama. Ma dopo Obama, ad insediarsi alla Casa Bianca è stato Donald Trump, un uomo che era stato denunciato per essersi rifiutato di affittare a neri negli anni 80, tra le altre cose, con legami piuttosto espliciti alla destra neonazista.
L’elezione di Trump ha palesato una verità ovvia: gli otto anni di Presidente nero non hanno cancellato il razzismo, né hanno radicalmente mutato l’ineguaglianza che ostacola il sogno americano.
Non è quindi meramente una questione di colore di pelle o colore politico, come dimostrò la presidenza Clinton, democratico la cui legislazione di diritto penale fu il coronamento di quelle dei suoi predecessori repubblicani, notoriamente Reagan e Nixon, che avevano iniziato il processo dell’incarcerazione di massa degli afroamericani e dei latini attraverso politiche strategicamente razziste e violente come lo “stop and frisk” di New York, che di fatto sospende l’habeas corpus, permettendo alla polizia di detenere temporaneamente e interrogare persone scelte anche in maniera possibilmente aleatoria, senza che quindi si abbia nulla di più contro di esse di un sospetto che non deve nemmeno essere formulato, strutturato o spiegato e può quindi benissimo essere basato sul nulla o non esistere del tutto.
Gli afroamericani, tutti quanti, a prescindere dalla loro condizione socioeconomica, vivono nel giustificato terrore della polizia, che storicamente ed attualmente è addestrata all’azione più che alla reazione e che ha palesemente un implicito pregiudizio, rafforzato dalla rappresentazione mediatica, circa la maggiore pericolosità dei neri o circa la minore dignità intrinseca delle loro stesse vite.
Pregiudizio che non solo fa uccidere, ma fa anche incarcerare ingiustamente.
Esistono miriadi di casi esemplari di persone nere innocenti private coattivamente della libertà perché i funzionari di un sistema convinto della loro pericolosità hanno trasferito aprioristicamente questa convinzione sulla loro colpevolezza nella fattispecie. Famoso è quello dei “Central Park Five“, cinque ragazzi tra i quattordici e i sedici anni che hanno passato anni in prigione per uno stupro avvenuto nel 1990 che non avevano commesso e contro i quali la polizia non aveva alcuna prova se non le confessioni estorte, attraverso violenza e minacce, ai ragazzi stessi, scelti praticamente a caso semplicemente per il colore della loro pelle, che li avrebbe resi credibili come mostri agli occhi dei media e della società. Altro caso famoso è Kalief Browder, sedicenne newyorkese fermato dalla polizia che lo accusava di aver rubato uno zainetto due settimane prima ed inviato per tre anni a Rikers Island, isola adibita a carcere la cui chiusura è in programma in virtù degli orrori che vi accadono. Browder passò anni tra i pestaggi di gruppo e l’isolamento in una stanza minuscola, senza luci, con solo dei ratti enormi come compagnia, per ventiquattro ore al giorno per mesi di seguito, pratica dichiarata tortura dall’ONU; tutto questo mentre aspettava il processo del caso per il quale rifiutava di dichiararsi falsamente colpevole, aspettava in prigione perché la sua famiglia non poteva permettersi di scarcerarlo pagando una cauzione. Kalief uscì e dopo poco si suicidò a ventuno anni, schiacciato dal peso sovrumano del trauma e dramma disumani che gli erano stati inflitti da questo sistema che non fu creato per lui, ma contro di lui.
Uscito di prigione, Browder, come tutti, non ricevette altro che gli effetti personali con cui era stato arrestato, la sua fedina penale fu sporcata, cosa che gli imponeva una maggiorazione di otto volte del premio di assicurazione sanitaria, l’impossibilità dell’assegnazione di una casa popolare, il pregiudizio che lo lasciava nell’effettiva impossibilità di trovare un lavoro o un’abitazione; insomma, le condizioni perfette per spingere una persona a delinquere, anche se non l’aveva mai fatto prima, anche se non lo voleva fare, tanto ha già imparato a combattere in carcere, tanto ha già appreso le regole ferree del codice della strada in carcere, tanto è già morto in carcere.
La gravità del trauma trans-generazionale è immensa, e modula e condiziona non solo l’idea che gli afroamericani hanno del mondo e di se stessi, ma anche la loro gestualità, i loro comportamenti, i discorsi che affrontano con i loro figli, primo tra tutti: cosa fare se fermati dalla polizia.
La portata del problema è enorme considerando che gli Stati Uniti hanno la prima popolazione carceraria al mondo con 2,3 milioni di persone, di cui il 37% sono neri, nonostante questo gruppo demografico costituisca solo il 14% dei cittadini.
George Floyd era stato arrestato perché aveva pagato con una banconota falsa, stando a quanto dicono. Inizialmente, la polizia aveva giustificato il suo delirante omicidio dicendo che l’uomo avesse resistito all’arresto in maniera violenta. Il giorno dopo, video di passanti e di telecamere di sorveglianza hanno dimostrato che, invece, George era già stato pestato da quattro agenti nella camionetta prima di essere vigliaccamente e brutalmente soffocato e che era uscito dal negozio camminando, composto ed in silenzio, non aveva quindi mai resistito all’arresto.
Grazie alla tecnologia, che permette a chiunque di essere regista della storia e ai social media, che permettono di esserne spettatori e testimoni, George avrà giustizia, ma i diciotto uomini e donne che avevano già segnalato abusi da parte di Chauvin e non avevano il video, no. Ma coloro che sono stati freddati durante un controllo di routine perché il poliziotto pensava che stessero prendendo una pistola mentre invece stavano allungando le mani per prendere la patente come era stato loro richiesto, no. Ma Tamir Rice, ucciso a dodici anni mentre camminava per strada senza che il poliziotto che ne fu colpevole fosse mai neppure arrestato, no. Ma i ragazzini del South Side di Chicago che sopravvivono in povertà, resistendo alle lusinghe della vita da criminale con tanto (illusorio) potere e tanti (veri) soldi, per poi essere fermati, insultati e picchiati dalla polizia per il solo fatto di essere neri, no. Ma tutti coloro che sono stati arrestati per raggiungere una quota della polizia o del carcere privato, che guadagna per ogni essere umano privato della libertà tra le sue mura, no.
Il colore è una piaga che ha distrutto le vite morali di bianchi e neri negli Stati Uniti e George Floyd, insieme con le altre ventinove persone di colore uccise dalla polizia dopo di lui, ne sono una prova, per niente sorprendente. Ciò che è sorprendente è la risposta internazionale, emozionale e razionale alla barbarie assoluta del suo omicidio, che funge da speranza per un futuro libero dalla pandemia del razzismo. “And still, I rise”, scriveva Maya Angelou, e ancora innalzeremo, tutti insieme, tutti uniti, bianchi, neri, asiatici, indigeni, ogni volta che sarà necessario finché non lo sarà più.
Fino a quel giorno, Black Lives Matter.
A cura di Francesca Sanneh